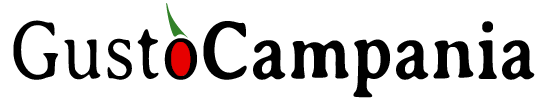Tra vino e pomodorini del piennolo: il Vesuvio, un vulcano generoso

Fino alla disastrosa eruzione del 79 d.C., i Romani ignoravano che il Vesuvio fosse un vulcano attivo. In compenso Strabone sottolineava la «mirabile fertilità delle pendici della montagna», attribuendola a una pregressa attività vulcanica. In effetti i terreni vesuviani sono fertili, oltre che per il clima mediterraneo, per il drenaggio delle acque favorito dalla loro giacitura e, soprattutto, per l’alto contenuto di potassio delle lave. La composizione dei suoli e la particolare storia geologica del territorio hanno favorito, in particolare, la viticoltura e la produzione di ortofrutticola di qualità.
Come e più di altre aree vulcaniche, il Vesuvio è, da millenni, terra di grandi vini. Haec iuga quam Nysae colles plus Bacchus amavit . “Bacco amò queste colline più delle native colline di Nisa” scriveva Marziale. Qui l’uva ha un sapore e un profumo inconfondibile. La fama di questo meraviglioso angolo di mondo e del suo vino ha fatto fiorire miti e leggende: “Dio riconoscendo nel Golfo di Napoli un lembo di cielo asportato da Lucifero, pianse e laddove caddero le lacrime divine sorse la vite del Lacryma Christi”. Sulla leggenda ritornò Curzio Malaparte che ne La pelle, invita a bere “questo sacro, antico vino”. La zona di produzione comprende solo le aree a vocazione viticola di 15 comuni, in provincia di Napoli, localizzati sulle pendici del Vesuvio, dove i vigneti ospitano varietà autoctone, da sempre coltivate in questa zona, come il Coda di volpe, localmente detto “caprettone”, e la Verdeca a bacca bianca; il Piedirosso, detto “pere ‘e palummo”(piede di colombo) per il caratteristico colore rossastro della parte iniziale del raspo, e lo Sciassinoso a bacca rossa. Recentemente a questi vanno aggiungendosi altri vitigni meridionali (come la Falanghina e il Greco per i bianchi, e l’Aglianico per i rossi) che, però, possono concorrere alla composizione del vino in misura non superiore al 20%. Da queste uve si ricavano vini che ora possono fregiarsi della Doc Lacryma Christi. Una delle produzioni più caratteristiche dell’area del Vesuvio, sono i pomodorini da serbo “col pizzo”, detti anche spongilli o piennoli (“pendoli”) per l’abitudine di appenderli alle pareti o ai soffitti, riuniti in grappoli (schiocche) e legati con cordicelle di canapa. Sono piccoli pomodori dalla forma a ciliegia, che si distinguono dagli ormai famosi pomodorini di Pachino per la presenza di squadrature laterali vicino al picciolo e di una punta, un “pizzo”, all’estremità. La buccia è resistente, la polpa soda e compatta, povera di succo, prosciugata dal sole che splende sui terreni del vulcano. L’antico procedimento di conservazione prevede che li si raccolga a grappoli interi all’inizio dell’estate per conservarli, appesi in locali ventilati, fino all’inverno o addirittura alla primavera successiva. Così, per molti mesi, si possono condire i pesci, le pizze e le paste della tradizione campana con una “pummarola” straordinariamente saporita. Se i pomodorini a piennolo sono noti quasi solo sul mercato locale, a milioni di consumatori sarà accaduto di assaggiare le albicocche del Vesuvio; ma senza accorgersene, perché la maggior parte della produzione è quasi totalmente assorbita dall’industria delle confetture.
Una fine anonima e ingloriosa per le antiche varietà di crisommole che nobilitano il panorama della frutticoltura vesuviana.E poi ci sono frutti che interessano meno l’industria e che per questo stanno scomparendo: è il caso delle ciliegie Malizia (rosso rubino intenso, con polpa succosa, aromatica e poco aderente al nocciolo) e del Monte delle prugne di Somma (la Pazza e la Pappagona),
ma anche delle castagne, delle nocciole, delle noci. Queste ultime sono ormai così rare che i produttori di nocino, un liquore che sta conoscendo una seconda giovinezza, hanno difficoltà a procurarsi in loco la materia prima, nonostante questa sia la terra delle noci di Sorrento, le più pregiate d’Italia.
Giovanni Porta
L’Apostrofo, Pomigliano d’Arco